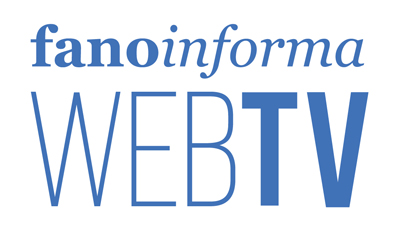Fano (PU) – La famosa “battaglia delle arance” del carnevale di Ivrea fu istituzionalizzata nel 1808 ma come si evince da due bandi datati 1872 e 1897 (il che non esclude possano esser riferiti a vecchie usanze) anche nel carnevale di Fano il lancio dei dorati agrumi non era sconosciuto. Si parlava infatti di divieto di scagliare “aranci” (ovviamente non gli alberi, ma i loro frutti). Nel primo bando, firmato il 6 febbraio 1872 dal sindaco di Fano, il conte Gregorio Amiani, si leggeva: “Nel gettito, detto de’ coriandoli, è permesso soltanto di usare le confetture buone, quelle di Benis, ed anche di gesso; ma è strettamente vietato di lanciare altre materie, come gesso, terra gialla o rossa, ghiaia, cenere ed anche aranci ed altri pomi, quando questi siano scagliati in modo che possano offendere”.
La seconda disposizione è del 24 febbraio 1897, firmata dal sindaco, prof. Giuseppe Scipioni. Vi si leggeva: “Lungo il Corso dalla Barriera Vittorio Emanuele all’Arco di S. Antonio e in Piazza XX Settembre è vietato il transito di qualsiasi rotabile ad eccezione delle vetture che il giorno 2 Marzo prenderanno parte al corso mascherato. Allo scopo di evitare disgrazie nella Corsa di Cavalli con fantino, ciascuno dovrà esattamente attenersi alle disposizioni che saranno date dalla Forza Pubblica e dagli Agenti Municipali. E’ vietato il gettito di aranci e di qualunque altra cosa che possa recar danno od incomodo”. Mi ha incuriosito, nel primo bando, oltre la citazione delle confetture di gesso (i “mandulòn” nel Carnevale di Fano si sono lanciati sino agli anni ’50) e del lancio di gesso e terra (diventati più ricchi è arrivata la farina) quel riferimento a “le confetture buone, quelle di Benis”. Di Benis non avevo mai sentito parlare e, a prima vista, pensavo si trattasse di qualche marca dolciaria. Grazie ad Internet ho poi scoperto che “benis” è il nome che i milanesi davano ai confetti che, assieme a fiori, venivano lanciati dai carri durante il carnevale meneghino sin dal Cinquecento. Ma fra il Carnevale di Milano e quello di Fano ci sono altre cose in comune. A Milano nel Settecento si cominciarono ad usare piccoli confetti di zucchero con all’interno un seme di coriandolo chi, troppo costosi per il popolo, furono gradualmente sostituiti (così come avvenne a Fano) da piccole pallottole, di identico aspetto, ma fatte di gesso, i cosiddetti “benis de gess”.
L’usanza sembrò gradita alle autorità, tanto che, nel 1808 il Prefetto di Milano, parlando dei piccoli proiettili di gesso li definì “le sole materie tollerate ad uso delle maschere da scagliarsi per le vie di Milano in Carnevale”. Al solito però si esagerò perché il lancio dei piccoli benis de gess diventò una vera e propria battaglia fra le maschere dai carri e la folla che “rispondeva”, spesso utilizzando anche delle specie di fionde. Ci si difendeva con “l’ombrella del sabet grass”, un ombrello molto più robusto del normale (a Fano gli ombrelli servivano per raccogliere i dolciumi) e proteggendo il volto con una spessa reticella: l’antenata delle visiere di plastica anti-getto del Carnevale di Fano. Ultima curiosità: fu un ingegnere milanese, Enrico Mangili, ad inventare i piccoli dischetti di carta (usando i dischetti di scarto dei fogli bucherellati che si usavano come lettiere per i bachi da seta) che furono poi chiamati coriandoli; e, ispirandosi ai nastri di carta su cui arrivavano i messaggi del telegrafo, inventò poi anche le stelle filanti.
Carlo Moscelli